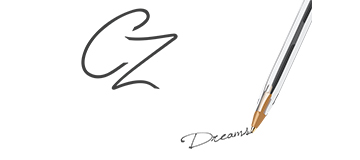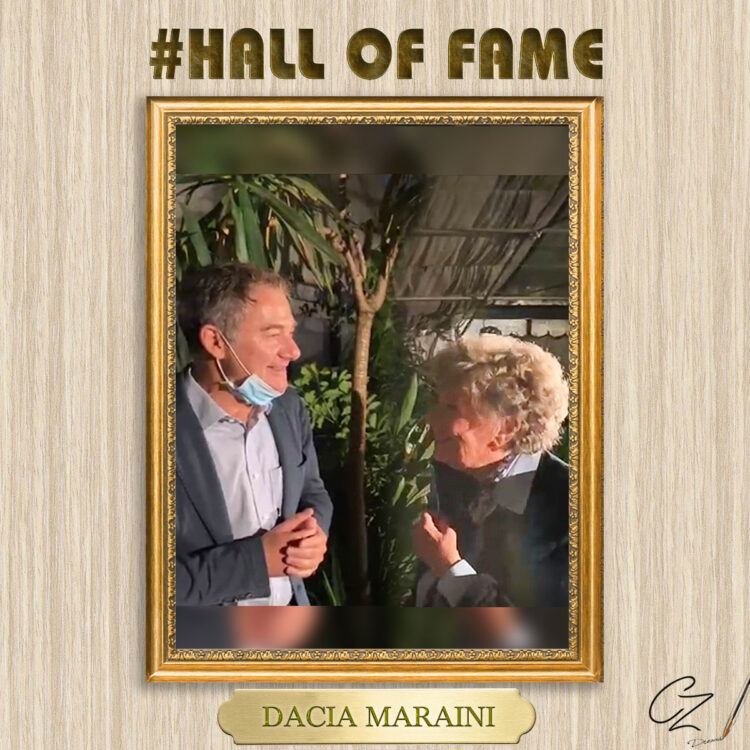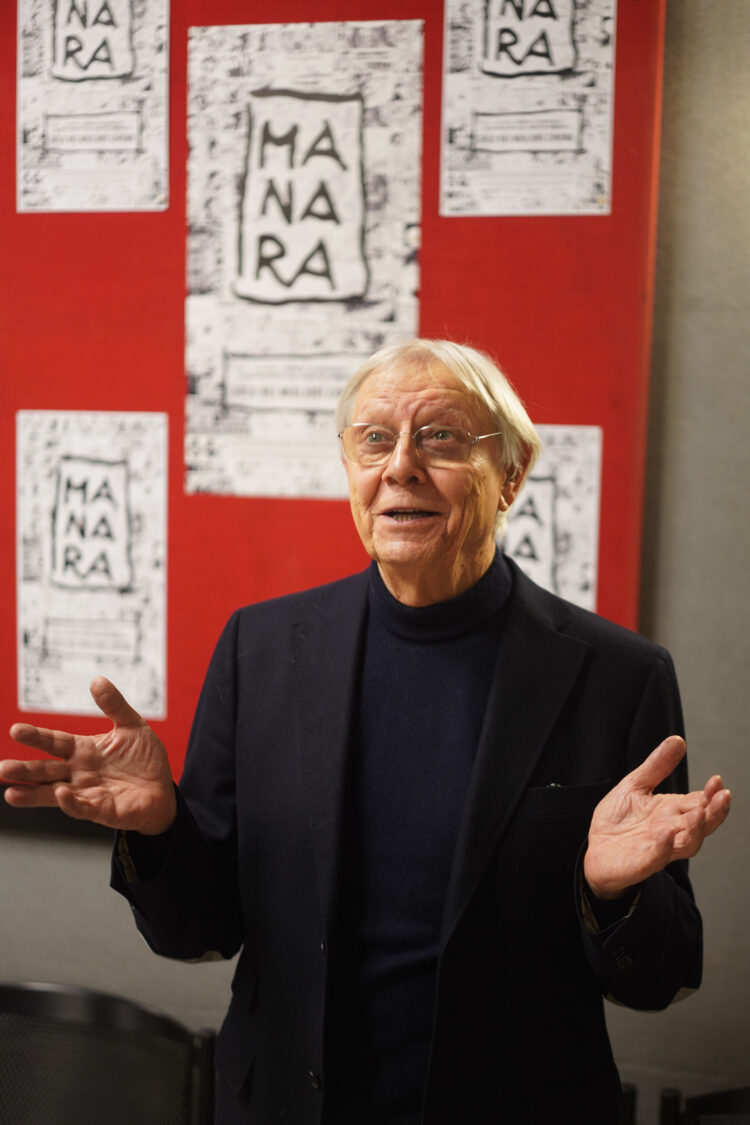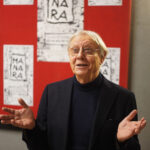Dacia Maraini è riconosciuta tra le più grandi scrittrici contemporanee, probabilmente la figura più cosmopolita della nostra storia letteraria. Nata a Firenze da famiglie toscane, siciliane e con quattro nonni di Paesi diversi.
Dacia Maraini ha trascorso un’infanzia anche contrastata con un periodo molto duro in Giappone a fianco del padre di cui ci racconterà nell’intervista, Fosco Maraini: celebre scrittore, antropologo e viaggiatore.
L’ottava edizione del Festival della Bellezza, per l’occasione in trasferta a Firenze presso lo splendido Giardino Torrigiani, verrà ricordato anche per questo magnifico appuntamento con la grande scrittrice.
Riporto per intero il dialogo tra Dacia Maraini e la coordinatrice del Festival Alessandra Zecchini. Un viaggio amichevole che ha affascinato per tutto il tempo un ampio e preparato pubblico.
az Può raccontarci che significato hanno avuto per lei i suoi legami familiari, i suoi riferimenti e l’esperienza dei viaggi?
Dacia Maraini Certamente noi siamo anche un po’ figli dei parenti di dove veniamo. Il fatto che io abbia quattro nonni tutti di paesi diversi, una nonna cilena, una nonna inglese, un nonno siciliano e un nonno svizzero non è male. Cosa mi ha dato questo? A me ha dato prima di tutto un’idea abbastanza aperta del mio destino familiare. Secondo, una disponibilità a interessarmi dell’altro.
Questo viene però anche da mio padre che era antropologo e che mi ha dato una impronta proprio storica e antropologica. Credo sia stato un insegnamento molto importante per me. E poi anche i viaggi. Perché non sono soltanto le origini, ma il fatto che a un anno io ero su una nave per il Giappone, per Tokyo. Questo significa molto, significa avere come esperienza primaria il viaggio. Per me il viaggio è una normalità, non è un cambiamento decisivo nella mia vita quotidiana. Viaggiare è proprio un pensiero. Credo di avere risposto alla sua domanda.
az E poi ha anche compiuto numerosi viaggi nella sua vita e anche in compagnia. Lei ha frequentato, è cresciuta, ha vissuto in un ambiente letterario estremamente stimolante e con personalità come Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini e Maria Callas avete fatto dei lunghi viaggi insieme. Ha qualche ricordo?
Dacia Maraini Pasolini credo lo conosciate tutti. Era un uomo straordinario che aveva delle grandi virtù profetiche. Credo che noi oggi ancora ci stupiamo per come lui abbia anticipato alcuni dei mali che stiamo vivendo in questo momento. Però la cosa curiosa di Pasolini era che lui nella vita privata era un uomo dolcissimo, un uomo mite, gentile, assolutamente incapace di fare male a una mosca. Veramente. Mentre poi nella vita pubblica, quando scriveva sui giornali, quando scriveva le poesie, quando era nel momento polemico, diciamo così, era molto provocatorio. Tanto è vero che tutti pensavano che lui fosse così anche nella vita, che fosse un uomo violento.
Pasolini è stato anche accusato e processato per violenza e invece lui non ha mai fatto violenza, non solo con me che ero un’amica, ma anche in generale. Come ho detto, Pasolini nella vita era dolcissimo.
Moravia era un uomo razionale, infatti Alberto e Pierpaolo si volevano molto bene perché si compensavano. Alberto credeva di avere ragione nella storia, nella razionalità e Pierpaolo invece credeva nell’istinto, nel rapporto emotivo con le cose e quindi andavano d’accordo come a volte si va d’accordo fra persone di temperamento diverso ed erano molto amici.
In quanto alla Callas, posso raccontarvi quando Pierpaolo mi disse “Sai, il prossimo viaggio in Africa lo facciamo con Maria Callas” io ho avuto un momento di panico perché ho detto: “Ma come si fa a viaggiare con una specie di mostro sacro, una donna così importante? “. Avevo paura che lei avrebbe voluto gli alberghi di lusso e tutti i servizi a cui era abituata. Invece quando l’ho vista venire all’aeroporto con i blue jeans un po’ stracciati e un’aria timidissima ho capito che forse mi ero sbagliata, perché lei nella vita era una persona molto timida e impacciata.
C’era questa cosa curiosa: lei era molto innamorata di Pierpaolo e Pierpaolo pure l’amava. Però era un amore platonico, succede. Succede anche di amare senza eros. E tutti sapevano che Pasolini era omosessuale, però si innamorava anche delle donne. Lei avrebbe voluto un rapporto totale, avrebbe voluto un matrimonio, addirittura, ma in questo lui non era d’accordo. Comunque, era curioso viaggiare con questa compagnia e devo dire che era un Africa diversa. Forse oggi chi vede questo continente non può capire che cos’era l’Africa negli anni 68/70. Era un Africa poverissima. Poverissima, ma sana. Voglio dire: non c’era quello che oggi guasta l’Africa. Anche da altri Paesi che noi conosciamo, come l’Afghanistan, tanto per dire, con il fanatismo religioso che allora non c’era. Questo è il punto.
Ci sembra che il fanatismo religioso sia sempre esistito ma non è così, tra l’altro io nel ‘79 sono stata in Afghanistan, ma non c’era nemmeno una donna con il burka. Le donne andavano all’Università, studiavano ed era tutto un altro mondo. Noi non pensiamo come velocemente una società si possa trasformare quando il fanatismo religioso entra nello Stato. Il momento in cui lo Stato si identifica come religione è un disastro. E noi lo sappiamo, perché da noi è successo, non è che non è successo.
È successo nei secoli passati, ma abbiamo avuto anche noi momenti terribili di totalitarismo religioso in cui la Chiesa si identificava come Stato, il peggio che possa succedere. Nei Paesi dove succede è un disastro e le prime a pagare sono le donne perché sono considerate pericolose. Pericoloso studiare, pericoloso lavorare, pericoloso avere delle proprie idee e più autonomia, eccetera. Quindi per tornare al discorso: l’Africa che noi conosciamo era un’Africa poverissima ma non ancora inquinata o potrei dire “avvelenata” dal fanatismo religioso, per cui andavamo dappertutto.
Noi uscivamo dalle strade turistiche, andavamo con la Land Rover proprio fuori dove non c’erano alberghi, dormivamo nelle tende. Era un viaggiare fuori dal raggio turistico e in questo devo dire che Maria Callas è stata straordinaria, si adattava a questo genere di viaggio, che era un viaggio molto avventuroso pieno di pericoli e difficoltà, però appunto non pericoli come ci sono oggi. Oggi non consiglierei di andare in giro per l’Africa senza essere protetti in qualche modo. Oggi no, non si può fare, ma allora si poteva fare. I cambiamenti sono stati rapidissimi, poche decine di anni ed è cambiato tutto.
az Quindi quanto ha influito sulla sua vocazione letteraria essere cresciuta con un padre come il suo, avere poi conosciuto e frequentato queste grandi figure del tempo?
Dacia Maraini La vocazione letteraria è molto precedente, anche quella è di famiglia. Io avevo una bisnonna inglese che si chiamava Cornelia Buckley che scriveva libri per bambini. Mia nonna Yoï Crosse Buckley scriveva romanzi di viaggio. Quindi nella mia famiglia i libri e la scrittura erano un bene e un valore. Anche quando eravamo poverissimi c’erano tanti libri, molti libri in inglese ma tantissimi libri. Io ho cominciato a scrivere a 13 anni per il giornale della scuola. A Palermo, perché mio padre aveva questa famiglia palermitana e quindi ho cominciato a scrivere per il giornale della scuola Garibaldi. Poi ho sempre continuato. Avevo già una mia personalità stilistica nel momento in cui sono entrata nel mondo letterario romano. In un certo senso per fortuna, forse, perché mi portavo dietro qualcosa che era più legato alla tradizione familiare che non alle conoscenze.
az Infatti, lei è autrice di molti romanzi tradotti in tutto il mondo in moltissime lingue, anche orientali, e anche di molte opere teatrali e di una decina di raccolte poetiche. Ci può dire il motivo per cui ha scelto di scrivere ed esprimersi in queste tre diverse forme letterarie?
Dacia Maraini In realtà gli scrittori si cimentano con le parole anche in campi che non sono soltanto il romanzo. Per esempio, i grandi romanzieri del passato hanno scritto anche teatro e poesie. Uno scrittore può divagare. Il caso più eclatante è Pirandello che naturalmente ha scritto tanto teatro, ma anche tanta prosa. Se uno va a vedere sono tantissimi. Perfino Svevo che neanche immaginavo. Ma ha scritto del teatro anche Manzoni. Gli scrittori in genere sono attratti e interessati da altre forme letterarie, perché il teatro e la poesia hanno a che fare con le parole. Naturalmente c’è una grande differenza tra i vari campi, però sempre si ha a che fare con le parole.
az Che differenza c’è tra l’immaginazione e poi la composizione tra queste tre forme? Si sceglie prima un soggetto? E in quali forme lo si esprime?
Dacia Maraini Il romanzo ha a che vedere con il passare del tempo. Non si può scrivere un romanzo in due pagine, non è una regola e nessuno stabilisce che il romanzo debba essere lungo più di cento pagine, però in realtà è così perché ha bisogno di una struttura lunga nel tempo. Il romanzo racconta il mistero del passaggio del tempo e quindi ci vuole una storia che si sviluppa nel tempo.
Nel teatro accade invece il contrario. Il teatro è contratto, di solito avviene tutto nel momento in cui vediamo la scena sul palcoscenico. Di solito si prende una giornata o un momento. Nel teatro c’è una contrazione del tempo prima di tutto ed è profondamente simbolico. Se io donna prendo un berretto da uomo e me lo metto in testa, salgo sul palcoscenico e dico che sono uomo: lo sono. Ricordiamoci che Sara Bernat, grandissima attrice dell’800 francese, ha recitato il giovane Napoleone quando aveva ottanta anni ed era senza una gamba. Le era stata amputata una gamba perché malata. Era una donna, non si vestiva e truccava da uomo, faceva l’uomo. E si crede a questo perché il teatro è così. Nel teatro tu dici, ad esempio, che un uomo è una donna e una donna è un uomo, ma puoi anche dire che una vecchia attrice è una ragazzina e ci credi perché è simbolico. Mentre il cinema è realistico non è simbolico, quindi se dici che è una ragazza deve essere una ragazza e se dici che è un giovanotto è un giovanotto, non puoi fare questa traslazione.
E poi la poesia che è tutt’ altro, perché la poesia ha a che vedere con il suono. Tra fonema e semantema nella poesia prevale il fonema: il suono della parola. Perché è tanto difficile tradurre la poesia? Perché perdi il suono delle parole. Nel dire “cane” e poi dire “dog” casca tutto, perché se tu prepari una riga o una frase sul suono “cane” fatto di due sillabe non funziona più se levi quelle due sillabe. Questo è il punto. Non funziona più se il suono cambia, per quello è quasi impossibile tradurre la poesia. E comunque la poesia è un progetto assolutamente musicale. Un autore (magari prevalentemente può essere un poeta, un romanziere o un teatrante) è sempre attratto da un campo in cui prevale la musica o il simbolismo e quindi ci prova. Posso dire che quasi tutti i grandi autori del passato hanno sperimentato. Poi ci si dimentica, ma da Čechov a Dostoevskij tutti hanno in qualche modo provato o la poesia o il teatro.
az Questa edizione del festival è dedicata a Dante e alla poesia. Dante è considerato il padre di una lingua viva che rende letteraria e meravigliosa. Inventa anche parole e sostantivi da verbi latini, crea immagini e anche modi di dire che noi usiamo ancora oggi.
Anche suo padre è stato inventore e ha scritto versi, per altro Stefano Bollani lo ha musicato e l’aveva proposto anche a una serata del Festival qualche anno fa. Questo per chiedere il rapporto cui accennava prima tra significato e sonorità della parola e il ritmo non solo nella poesia ma anche nella prosa.
Dacia Maraini Quella struttura musicale che nella poesia è evidente, chiarissima e primaria, nella prosa meno, è più recondita… ma esiste… è vero sono d’accordo. Io addirittura arrivo a credere che quello che permette a un romanzo di comunicare delle emozioni è la struttura nascosta che c’è in ogni scrittura poetica musicale. Tutte le forme di scrittura hanno una piccola struttura musicale interna, a volte visibile come nella poesia a volte meno visibile come nella prosa, ma c’è.
E secondo me è quella che poi comunica. Perché non basta scrivere una bella storia bisogna sapere comunicare e secondo me si comunica attraverso questa struttura musicale sotterranea, ma che negli scrittori veri a un certo punto si fa strada, comunica attraverso questo ritmo e questa musicalità.
Riguardo a Dante Alighieri, io come tutti, ho ripreso in mano la lettura di Dante. In questo periodo se ne parla molto e non mi era così chiaro quanto Dante fosse rivoluzionario. Rivoluzionario perché lui si riferiva alla cultura provenzale, che in una Europa verticistica e totalitaria era una grande novità e rivoluzione, ed era basato sull’idea cavalleresca del rapporto leale con l’avversario. Un’idea che troviamo oggi nello sport.
E poi una cosa importantissima era il rapporto diverso con le donne, perché fino ad allora le donne erano una proprietà familiare. Le donne non contavano proprio niente, meno degli animali. La cultura che poi si esprime attraverso i poeti trovatori tirando fuori la compagna d’amore e dandole una spiritualità che non le era mai stata data è una cosa straordinaria. Anche se poi si teorizza un amore privato dell’Eros.
Infatti, una cosa buffa della cultura provenzale e dei poeti trovatori era che loro predicavano l’amore e tutto si risolveva nel grande amore per una dama, però questa dama era sposata. E la cosa buffa di Dante è proprio questa. Dante condanna e mette all’inferno gli adulteri, Paolo e Francesca come famoso esempio, però allo stesso tempo lui era sposato e Beatrice era sposata e aveva pure quattro figli. Quindi Dante da una parte condannava l’adulterio, dall’altro seguendo questa meravigliosa innovazione della cultura provenzale ne fa invece un inno all’adulterio.
Questa è la cosa comica in un certo senso. Naturalmente in una lettura tradizionale questo fatto non emerge, ma riflettendo dal punto di vista delle donne viene fuori questa contraddizione che però è bellissima perché è esplosiva.
az Molto interessante. Forse è veramente la svolta di un’epoca questo passaggio tra una gerarchia che è nel mondo letterario e poetico, ma in cui si afferma la superiorità della donna e del cuore della donna.
Dacia Maraini Soprattutto le si da un’autonomia spirituale e una capacità di pensiero che prima proprio non esisteva nella cultura greca. Nella meravigliosa e grandissima cultura greca le donne contavano pochissimo, come nella cultura romana. Quindi è una novità straordinaria. Anche nella cultura medievale prima di Dante questa straordinaria novità ha cambiato molto le cose, da lì secondo me piano piano viene fuori quella grandissima rivoluzione che è stato il Rinascimento.
Dal Rinascimento poi viene fuori, due secoli dopo, la società degli illuminati. L’Illuminismo ha le sue radici proprio nel Rinascimento durante il quale l’Italia era al centro dell’Europa. Alla corte francese si parlava italiano: il teatro italiano, la Commedia dell’Arte. E tutti dicono “La commedia dell’arte… l’improvvisazione…” ma non è così. Non è l’improvvisazione la cosa più importante successa nella commedia dell’arte, ma è che per la prima volta nella storia del mondo occidentale le donne salivano sul palcoscenico.
Ricordiamoci che nel teatro greco le donne non avevano accesso al palcoscenico, erano uomini che si mettevano la maschera e facevano i personaggi femminili. Idem nel teatro romano. Sembra che nel teatro etrusco ci fosse una maggiore libertà, però la storia degli etruschi è stata concretamente distrutta dai romani. E i romani hanno raccontato la storia degli etruschi. Ne sappiamo poco, però nel Cinquecento per la prima volta le donne salgono sul palcoscenico: questa è la grande novità della Commedia dell’Arte. Ed è tale la novità rivoluzionaria che il teatro della Commedia dell’Arte italiana si trova ad andare in tutta Europa, mentre in Francia nasce il “théâtre à l’italienne”, che poi durerà per due secoli, basato su questa novità.
Gli studiosi del teatro si soffermano solo nel dire che era un teatro vivace fatto di maschere e improvvisazione ma non dicono mai che la novità stava proprio in questo: che per la prima volta le donne salivano sul palcoscenico. Ricordiamoci che Isabella Andreini scriveva addirittura i testi, cosa che era inconcepibile prima di allora. Bisogna ricordare queste cose della storia, ci dimentichiamo della storia che è importantissima.
az Nel melodramma, nel mondo dell’opera, ricollegandoci anche a Maria Callas, questo è avvenuto molto dopo… perché i primi passi femminili…
Dacia Maraini: Diciamo che da noi è mancato il romanzo popolare che è stato in qualche modo sostituito dall’opera del melodramma. Anche perché non abbiamo avuto una lingua nazionale fino al 1861. Noi avevamo delle lingue regionali. Non erano dialetti, erano lingue. Il toscano, il siciliano, il veneto erano lingue vere e proprie però spesso erano lingue non scritte quindi è stato difficile avere una letteratura nazionale. In Europa alcuni paesi ce l’avranno, come la Germania e la Francia che hanno per esempio tradotto la Bibbia in lingua nazionale e non avevano questa frammentazione linguistica che abbiamo avuto noi. ù
Questa mancanza è stata sostituita dal melodramma, cioè dalla musica che prevaleva sulla parola perché, diciamo la verità, i libretti non usavano un linguaggio parlato, usavano un linguaggio artificiale, artefatto, che infatti spesso dava fastidio.
Non è un caso che Manzoni mandava a sciacquare i panni di qua e di là perché sapeva che la lingua italiana non era la lingua dei mestieri. La gente era quella che faceva i mestieri, mestieri nel senso professioni. Quindi quelli usavano la lingua regionale e non c’era una lingua nazionale in cui esprimersi. Questo è il problema che abbiamo avuto noi, non esisteva una grande tradizione del romanzo seicentesco, settecentesco o ottocentesco. Abbiamo qualche esempio ma non abbiamo quel grande romanzo che ha avuto la Francia, la Germania, l’Inghilterra e anche la Russia.
az A proposito di lingue e dialetti, c’è una pagina molto bella all’inizio di Bagheria in cui lei racconta l’incontro, arrivando dal Giappone, con la lingua che si trova.
Dacia Maraini A parte il fatto che mi consideravano una piccola giapponese. Ero stata otto anni in Giappone. L’ho vissuta lì la prima infanzia, tutta giapponese, per cui io parlavo molto meglio il giapponese dell’italiano.
Quindi appena arrivata non solo m’incontravo con l’italiano, m’incontravo con il siciliano perché prima siamo andati a trovare la famiglia di mia madre in Sicilia. E lì si parlava in dialetto. “A Femmina cui calzi”, mia madre era uno scandalo perché portava i pantaloni. “A femmina cui calzi” era la donna con i pantaloni che allora faceva scandalo. Che cos’è una donna con i pantaloni? Non va bene.
az Secondo lei i poeti sono stati determinanti anche per definire la concezione della donna e quindi la sua emancipazione?
Dacia Maraini I poeti esprimono l’epoca loro. Qualche volta i poeti non è che siano più intelligenti però hanno le parole. Conoscono le parole per dire le cose che magari gli altri pensano ma non sanno dire (non solo i poeti, anche i filosofi).
Il pensiero comune, i grandi cambiamenti partono dal basso e dal sentimento comune di cambiamento, però spesso le persone dedite a dei lavori che non riguardino l’espressione linguistica letteraria non hanno le parole per dirlo.
I filosofi, i poeti e gli scienziati trovano le parole per dire delle cose. Parole che non sempre inventano loro, ma le esprimono. Quindi non è che loro cambiano il mondo però aiutano a creare una consapevolezza. Io credo che è questo il compito dello scrittore, certamente non quello di cambiare il mondo perché non potrebbe farlo, ma può creare consapevolezza. Il pensiero passa per il linguaggio e senza linguaggio il pensiero non esiste. Noi non possiamo pensare senza le parole, non c’è un pensiero senza parole e quindi più le parole sono allargate, sofisticate e complesse più aiutano a tirare fuori un pensiero complesso.
Io mi ricordo che Dario Fo ha scritto un testo teatrale che si chiamava “Il padrone conosce 1.000 parole e l’operaio 300. Insomma, l’importanza delle parole sta nel fatto che anche i diritti civili sono legati alle parole. Se tu sai pensare sai anche dire e chiedere i tuoi diritti, se non sai pensare perché non hai le parole non hai lo strumento anche della protesta o richiesta.
Per cui spesso i diritti civili partono da persone colte che hanno una proprietà linguistica. Oggi il nostro alfabeto è stato molto cambiato, però effettivamente chi ha la proprietà linguistica spesso ha una proprietà che serve anche alla comunicazione e ha un’arma in più.
az Nel mondo della traduzione il pensiero, la parola, certi concetti, pensare ed esprimere una frase in italiano e poi tradurla in tedesco o in lingue che hanno una struttura completamente diversa come le lingue orientali, bisogna avere a che fare con cambiamenti nella traduzione della propria opera?
Dacia Maraini Questi sono i problemi della traduzione. È molto difficile tradurre perché la lingua non è matematica, non è che si tratta di prendere i numeri e trasportali in un’altra lingua. Le parole hanno una storia, hanno una sensibilità, hanno un colore. Hanno soprattutto una storia.
Poi non parliamo delle metafore che cambiano da popolo in popolo e da storia in storia e li è difficile intervenire perché bisogna trovare un equivalente. Ogni parola ha una storia, ha un suono, una radice, ha un significato che va al di là della parola spesso per come viene usata.
Mi ricordo che tempo fa un certo punto mi sono trovata a scrivere la parola magico, poi sono uscita e su una parete di Roma ho trovato scritto “Magica, magica Roma”, ho detto “ecco, la parola magica è finita”. Se la parola magica viene usata per una continua esaltazione di una partita di calcio è chiaro che togli qualche cosa in questa parola, però trasportandola in un’altra lingua è difficile fare questo cammino linguistico.
az Dante è definito sommo poeta, un riferimento altissimo e irraggiungibile quindi quale può essere l’atteggiamento nei suoi confronti per chi scrive in versi in italiano?
Dacia Maraini C’è molto da imparare, la cosa straordinaria di Dante è che ancora sue moltissime espressioni fanno parte della nostra lingua. Forse c’è più distanza tra Shakespeare e l’inglese di oggi. Io ricordo che in Sicilia, negli anni Cinquanta, i contadini analfabeti ripetevano a memoria alcune frasi di Dante perché se le passavano e quindi erano diventate delle parole simboliche che avevano un senso nel momento in cui si pronunciavano.
Ancora oggi abbiamo molte frasi dantesche che usiamo nella lingua quotidiana.
Un’altra cosa importante di Dante e del poeta è quello di riuscire a comunicare sia con le persone colte, i grandi studiosi, i linguisti che con gente analfabeta come nel caso dei contadini siciliani, questa è la grandezza dello scrittore. Un grande scrittore comunica a tutti i livelli, è la sua forza.
az Questa edizione del Festival della Bellezza è dedicata all’espressione poetica. Il poeta in senso romantico è inteso come creatore anche in tutta una serie di sfaccettature e significati quasi filosofici che poi in senso stretto è l’autore di opere in versi. Qual è la sua idea di poeta? Si può affidare anche a chi si esprime in prosa o per immagini avendo conosciuto e frequentato pittori e musicisti. Il senso poetico dove e in cosa si trova?
Dacia Maraini Ecco, la poesia è autonoma. Oggi i ragazzi tendono a considerare poesia le canzoni ed effettivamente non sono più le canzoni di quando io ero bambina. Allora non c’erano i cantautori e le parole erano molto convenzionali. Invece oggi ci sono cantautori che hanno introdotto una maggiore consapevolezza linguistica nelle loro canzoni, che non sono basate solo sulla piacevole armonia ma anche sulle parole. Tanto è vero che adesso abbiamo addirittura la moda di canzoni in cui quasi la musica non c’è più, ci sono solo le parole. Però non è la stessa cosa. Non si può equiparare la poesia, che ha una autonomia assoluta, con le canzoni. Canzoni che sono nobilissime e bellissime, ma nella canzone la poesia è in qualche modo al servizio della musica.
Anche i grandi cantautori, per esempio, usano la rima che oggi in poesia non si usa più. Si usa un certo tipo di ritmo che è legata alla musica, mentre la poesia ha una musica sua interiore non ha bisogno di un’altra musica che le dia una visibilità o una orecchiabilità. La poesia ha la sua musica e quindi è autonoma e va da sé.
Posso raccontare una cosa che secondo me fa capire quello che io penso della poesia? Andando a visitare un campo di concentramento nazista in Polonia, ne sono interessata perché io ho fatto due anni in un campo di concentramento giapponese, ho trovato una memoria scritta che mi ha molto impressionato perché questa era di un giovane politico francese che è stato preso. Lui non era ebreo, però era comunista. Quindi è stato preso insieme ad altri francesi. Lui racconta che è sopravvissuto al campo un po’ perché era giovane e lo facevano lavorare, ma racconta una cosa che secondo me è essenziale.
Questo giovane politico dice che l’unico luogo del campo dove i nazisti non andavano era il cesso. Perché era sporco, puzzolente, non c’era acqua corrente e c’erano dei buchi per terra. Quindi i nazisti, tutti vestiti di bianco, non ci andavano. Allora cosa facevano? Questi giovani francesi si riunivano nel cesso del campo e si recitavano a memoria delle poesie in francese. Da questo si può capire cos’è la poesia. Lui dice “Se non fosse stato per quegli incontri segreti in cui noi ci recitavamo a memoria le poesie della nostra infanzia e della nostra vita io credo che non sarei sopravvissuto all’orrore del campo.” Io credo che la poesia abbia questa funzione, la funzione di farti sentire vivo. Credo che meglio di così non si potrebbe descrivere cos’è la poesia.
Però a proposito del romantico io non credo molto alla poesia come ispirazione romantica. Io credo che la poesia sia lavoro. I poeti lavorano, esercitano, sbattono la testa, si scontrano con le parole, fanno una guerra quotidiana con le parole. Ed è per questo che non c’è niente di romantico nella poesia, secondo me.
az I suoi poeti preferiti che l’hanno sempre accompagnata quali sono?
Dacia Maraini Io ho avuto una passione per Leopardi. Leopardi, per esempio, faceva politica. Politica nel senso delle parole. Parlava dell’Italia, quindi i poeti spesso si sporcano le mani.
Una poetessa che ho amato tantissimo è Emily Dickinson, la quale oggi è considerata la più grande poeta non solo delle donne ma anche dei poeti maschi americani. Lei scriveva con una tale originalità che i poeti della sua epoca non l’accettavano.
Emily Dickinson manda delle sue poesie a un famoso critico, c’è la lettera di questo famoso critico è interessante andare a vedere, e il critico le risponde dicendo “Si, c’è una certa grazia in queste sue poesie ma io credo che le mani delle donne siano fatte per il ricamo, per la pasticceria, per le carezze ma non siano adatte per la poesia “. Lei poveretta è rimasta talmente male che non ha più cercato di pubblicare e infatti non ha mai pubblicato nella sua vita una sola poesia. Quando è morta i suoi eredi stavano per buttare via tutte le poesie. La cognata Susy, che aveva capito la sua grandezza, ha detto “No, fermatevi. Aspettate “, ha preso la sua scatola di poesie e le ha, per fortuna nostra, tenute e conservate. Poi piano piano sono state finalmente scoperte.
Ma per dire nella sua vita non è mai stata apprezzata eppure chi conosce Emily Dickinson sa che è una grandissima poetessa, un grandissimo senso spirituale. La sua è una poesia spirituale però lei, che stava sempre in casa, guardava il mondo dalla finestra e capiva di questo mondo molto più di tanta gente che ci stava in mezzo.
az A conclusione di questo nostro bellissimo incontro: davvero un grande grazie. Una sua definizione di bellezza e dove si trova secondo lei la bellezza?
Dacia Maraini Grazie a voi. La bellezza per me è un fatto spirituale. Sì, esiste la bellezza dei quadri, della musica, dei fiori, però non è la bellezza commerciale che ci viene proposta continuamente attraverso la pubblicità. Lo trovo molto umiliante perché è una bellezza stereotipata, basata su un’idea di seduzione. Non mi piace l’idea della bellezza femminile che troviamo nelle riviste di moda, nelle pubblicità. Trovo sia molto umiliante.
La bellezza è invece un sentimento. Non è sempre facile capire la bellezza, però quando la si capisce ci si sente meglio. La bellezza comunica un senso di gioia, di allegria, di piacere di stare al mondo. Secondo me certe periferie di città producono violenza perché non c’è bellezza. Però non intendo la bellezza del consumo che ci viene proposta continuamente, ma la bellezza dell’armonia delle cose.
Ed è questa che non c’è in molte parti e quando non c’è bellezza viene fuori la violenza, viene fuori la bruttezza, anche spirituale, la bruttezza che nasce appunto con la mancanza del respiro della mente.
Io credo che la cultura del mercato in cui viviamo tende a proporre un’idea di bellezza molto disumanizzante, se posso dire questa parola. La resistenza sta nel cercare di portare avanti una bellezza molto più complessa e molto più profonda.